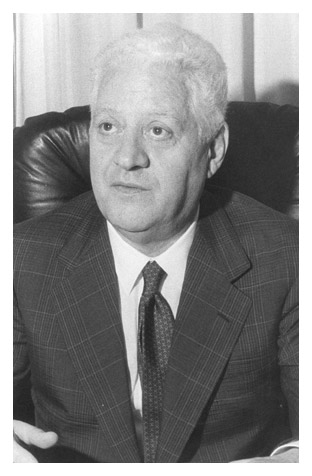 Il massiccio processo di urbanizzazione, lo sviluppo edilizio e
l'incremento del giro d'affari legato al mondo degli appalti per le opere pubbliche nel
periodo della grande ricostruzione, negli anni successivi al primo dopoguerra, favoriscono
la prima mutazione di Cosa Nostra, che comincia a guardare alle città come alle sedi
privilegiate dei suoi nuovi e lucrosi affari. Il massiccio processo di urbanizzazione, lo sviluppo edilizio e
l'incremento del giro d'affari legato al mondo degli appalti per le opere pubbliche nel
periodo della grande ricostruzione, negli anni successivi al primo dopoguerra, favoriscono
la prima mutazione di Cosa Nostra, che comincia a guardare alle città come alle sedi
privilegiate dei suoi nuovi e lucrosi affari. Il primo passo è il
controllo
dei mercati ortofrutticoli, che costituiscono il tramite tra la città e le risorse della
campagna, ove la forza e la presenza mafiose sono ormai consolidate. Ma il grande affare
di quegli anni è l'edilizia. Le famiglie mafiose passano rapidamente a occuparsi delle
operazioni di speculazione sulle aree edificabili, dove quote rilevanti di capitali
illeciti trovano facile sbocco e determinano improvvisi arricchimenti. In dieci anni, dal
1951 al 1961, gli abitanti di Palermo aumentano di centomila unità. Grazie alla
complicità di una nuova classe dirigente, talvolta diretta espressione di un voto
politico che nelle borgate e nelle periferie è fortemente condizionato dall'intimidazione
mafiosa, le "famiglie" ottengono il controllo diretto o indiretto dei piani
regolatori, del rilascio delle concessioni edilizie e della compravendita delle aree
edificabili. Si impossessano - inoltre - del circuito imprenditoriale indotto: cemento,
conglomerati, movimento terra, materiali per l'edilizia. Il primo passo è il
controllo
dei mercati ortofrutticoli, che costituiscono il tramite tra la città e le risorse della
campagna, ove la forza e la presenza mafiose sono ormai consolidate. Ma il grande affare
di quegli anni è l'edilizia. Le famiglie mafiose passano rapidamente a occuparsi delle
operazioni di speculazione sulle aree edificabili, dove quote rilevanti di capitali
illeciti trovano facile sbocco e determinano improvvisi arricchimenti. In dieci anni, dal
1951 al 1961, gli abitanti di Palermo aumentano di centomila unità. Grazie alla
complicità di una nuova classe dirigente, talvolta diretta espressione di un voto
politico che nelle borgate e nelle periferie è fortemente condizionato dall'intimidazione
mafiosa, le "famiglie" ottengono il controllo diretto o indiretto dei piani
regolatori, del rilascio delle concessioni edilizie e della compravendita delle aree
edificabili. Si impossessano - inoltre - del circuito imprenditoriale indotto: cemento,
conglomerati, movimento terra, materiali per l'edilizia.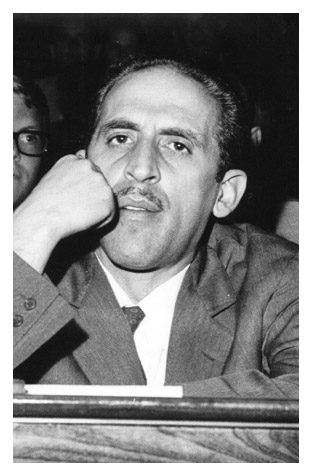
Dal 1959 al 1964 è sindaco Salvo Lima, vicino alla mafia di Stefano Bontate; assessore ai
lavori pubblici è Vito Ciancimino, legato ai "corleonesi" di Riina e
Provenzano.
Sono gli anni del "sacco di Palermo", realizzato all'insegna di un tacito
accordo tra mafia, amministratori pubblici e imprenditori, che diventerà molto presto un
modello criminale per moltissime aree del Mezzogiorno.
E' in quegli anni che nascono numerose attività imprenditoriali sostanzialmente
riconducibili a uomini d'onore o a loro parenti, congiunti e prestanome.
Attraverso l'impresa mafiosa, Cosa Nostra tenta di proporsi con un
ruolo apparentemente "pulito", avviando - nei fatti - un processo di capillare
infiltrazione nel tessuto economico e finanziario non solo siciliano, che negli anni a
seguire produrrà effetti distorsivi di portata internazionale.
Gli interessi economici che scaturiscono dal piano di sviluppo urbanistico delle città,
impongono un complessivo mutamente nei rapporti tra mafia e mondo della politica. Un
rapporto che - per forza di cose - non finisce con investire tutte le attività degli enti
pubblici, a cominciare dagli appalti, dalle locazioni e dalle grandi manutenzioni. Un
rapporto che - come sveleranno molti anni più tardi i collaboratori di giustizia -
diviene "criterio guida" per fare e disfare alleanze politiche, accordi di
coalizione e formule di governo. In quest'ottica, gli enti locali e i centri di
irradiazione della vita politica (il partito, la giunta comunale, provinciale o regionale)
divengono terreno per gli scontri e gli accordi tra gruppi politico-mafiosi, generando una
vera e propria cultura dello scambio, del rapporto permanente ed integrato tra potere
mafioso e potere politico.
Gli uffici dell'Amministrazione pubblica diventano il luogo in cui si consuma la perfetta
commistione tra politica, burocrazia, malaffare e criminalità mafiosa.
Il risultato è che in occasione degli appuntamenti elettorali, ogni candidato viene
appoggiato da una o più famiglie del mandamento mafioso in cui ricade la circoscrizione;
e all'interno di alcuni partiti - è il caso della Democrazia Cristiana - il consenso
proveniente delle "famiglie" di Cosa Nostra è cosa talmente scontata e ben
accetta, da indurre gli organi dirigenti del partito a disporre che in alcuni quartieri
della città venga presentato un determinato candidato piuttosto che un altro. |